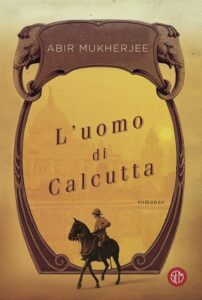Calcutta, 1919. Nella grande città dell’India coloniale avviene un omicidio. La vittima, ritrovata in uno squallido quartiere della Città Nera, è un alto funzionario dell’amministrazione britannica. In bocca gli è stato infilato un biglietto che condanna la dominazione inglese.
L’inquirente è il giovane capitano Sam Wyndham, arrivato da Londra solo da pochi giorni.
Wyndham è un reduce della prima Guerra Mondiale, che lo ha indelebilmente segnato nel corpo e nello spirito, e ha scelto di andare in India perché la guerra (insensata carneficina a cui molti sono andati incontro “come tanti tacchini che non vedono l’ora che arrivi il Natale”) gli ha portato via familiari e amici, e l’epidemia di influenza spagnola gli ha ucciso l’amata moglie. A dispetto dell’età, ha maturato esperienza nella polizia londinese, a Scotland Yard e nello spionaggio. Trova il clima del Bengala terribile: calore soffocante e umidità asfissiante interrotti da diluvi monsonici. E trova ingiustificabile l’alterigia con cui gli inglesi trattano gli indiani. Nonostante la sua simpatia per i locali e il suo scetticismo verso la presunta superiorità inglese, Sam Wyndham sa stare al suo posto e non si comporta né da intellettuale né da politico, ma da poliziotto.
Già nelle prime pagine si dispiegano gli elementi fondamentali del romanzo: una città inquieta e che mal tollera gli occupanti; un protagonista intelligente, ironico, dallo spirito aperto, ma anche sofferente e morfinomane; un omicidio che sembra di matrice politica e che a sua volta rischia di rintuzzare i disordini indipendentisti. Tutto infatti porta a credere che la colpa sia di uno degli innumerevoli gruppi che vogliono scacciare i dominatori dal Paese (intanto, all’orizzonte, si profila sempre più la ribellione non violenta propugnata da Gandhi, che, con il boicottaggio dei prodotti inglesi, sta incominciando a fare seri danni nella produzione e nel commercio).
Per questo è vitale concludere velocemente l’indagine. Solo individuando il colpevole si potrà capire se si tratta di una morte isolata o se è l’inizio di una vasta campagna terroristica contro il dominio coloniale. In un clima politico che si arroventa velocemente, un altro delitto, apparentemente scollegato, alza ulteriormente la posta in gioco.
Il romanzo è un giallo a tutti gli effetti, gradevole, scorrevole, piacevolmente spiritoso, con un bel ritmo e una trama intricata al punto giusto, costellata da colpi di scena.
Ma c’è anche dell’altro: un contesto storico e sociale accuratamente ricostruito. Quella in cui il lettore si ritrova è una Calcutta viva, popolata, divisa tra quartieri fatiscenti e altri monumentali, espressione architettonica delle fantasie imperiali inglesi. Una città raccontata e vissuta da un cittadino inglese che è a contatto con il mondo indiano, ma non ne fa parte. Il capitano Wyndham non ci offre un tuffo nella vita e nella società indiane, ma uno sguardo sugli inglesi in India e sul loro rapporto con la popolazione locale.
Scopriamo quindi una società non solo razzista e sprezzante verso gli indiani, ma anche classista al suo interno. Incontriamo espatriati che si sentono inglesi fino al midollo anche se non hanno più legami con la madrepatria, mercanti, funzionari, militari ottusi, un intero piccolo universo assolutamente certo che l’India è stata resa grande dalle idee, dalla civiltà e dalla tecnologia britanniche e che è terrorizzata dalle velleità indipendentiste: “Dopo tutto ciò che avevano fatto, come potevano i nativi avere la faccia tosta di volerli rispedire a casa?”.
Tutto il romanzo è attraversato da una riflessione sulla natura del colonialismo, ed è bello che questo si armonizzi alla perfezione con l’andamento della vicenda, senza artificiosità. Come è potuto avvenire che centocinquantamila inglesi abbiano controllato così a lungo trecento milioni di indiani? In che modo si è costruita l’immagine della superiorità inglese, non solo economica, organizzativa e militare, ma anche e soprattutto morale? Perché, ci dice il libro, è soprattutto su questa presunta superiorità morale che il colonialismo inglese si è fondato e legittimato. E come si è riusciti a instillare in tutti, inglesi e indiani, la convinzione che si tratta di affermare la moralità e i benefici della civiltà, quando in realtà sono solo benefici commerciali ed economici, perdipiù quasi a senso unico? In che modo il colonialismo può conciliarsi con le idee liberali e di autodeterminazione che sgorgano proprio dalla cultura inglese?
Non dimentichiamo tuttavia la domanda centrale del romanzo: chi è il colpevole?
Vi invito allora a seguire Sam Windham nella sua indagine, a schivare con lui ostacoli e ambiguità e a non cadere nella trappola di risposte frettolose. Per lui è in gioco la sua stessa carriera, per voi solo una bella lettura.