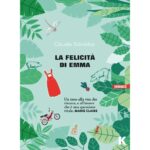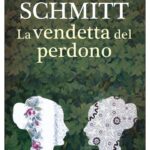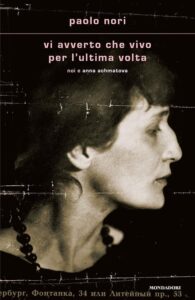Dopo essersi dedicato alla figura e all’opera di Dostoevskij nel libro Sanguina ancora, Paolo Nori si rivolge a un altro monumento della letteratura russa, la poetessa Anna Achmatova. Ancora una volta, il risultato è una biografia sui generis, la cui peculiarità è espressa già nel sottotitolo: Noi e Anna Achmatova. Sin dall’inizio è dunque chiaro che l’attenzione non sarà puntata esclusivamente sulla figura dell’artista, quanto sulla sua attualità, sul significato che la sua vita e la sua poesia rivestono per noi e il nostro tempo.
È bene sottolineare che l’approccio di Nori non è convenzionale, poiché impasta continuamente biografia e autobiografia. Ogni informazione sull’esistenza e l’opera di Anna Achmatova si aggancia a ricordi, aneddoti, impressioni dello stesso Nori, in modo da far sì che le vicende e le emozioni personali vengano a dare concretezza al mondo della poetessa. Questi rimandi, anche laddove potrebbero sembrare semplici divagazioni, in realtà offrono sempre spunti di riflessione e aiutano a comprendere empiricamente le liriche di Achmatova, partendo dalla loro ricezione soggettiva e tralasciando l’analisi formale e contenutistica. Quando Nori condivide con noi l’improvvisa scoperta della bellezza di un paesaggio che già tante volte ha attraversato in treno, ci sta indicando con immediatezza il senso di una poesia in cui Achmatova canta la lucentezza di un secchio; quando ci parla dell’amore che prova per la figlia e della consapevolezza lancinante della sua mortalità, sta di fatto riempiendo di significato vivo il verso del titolo, Vi avverto che vivo per l’ultima volta.
Accostarsi per questa via informale all’opera di un’autrice celebrata ha il pregio di mettere a suo agio ogni lettore. Nori non insegna, racconta. E lo fa in uno stile colloquiale, modulato sul parlato. In pagine a volte divertenti, a volte commoventi, disseminate di piccole vicende private, presenta Achmatova nella sua umanità e nelle sue contraddizioni e restituisce tutto il valore della sua opera. È un’operazione che mi sembra in linea con il suo lavoro di traduttore e docente di traduzione dal russo, oltre che di romanziere: sia in un caso che nell’altro, si tratta di ricondurre un contenuto psicologico, storico, sociale a un linguaggio noto, affinché diventi comprensibile e prossimo.
È stato peraltro proprio grazie ad Achmatova che egli si è innamorato della lingua e della letteratura russe: ancora studente, sentì una docente recitare una sua poesia e ne rimase conquistato. Il legame viscerale che ha con la cultura russa accresce a dismisura il suo sconcerto per il conflitto in corso. Nori, che è stato al centro di un vero e proprio caso all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina, quando un’università preferì annullare il suo ciclo di conferenze su Dostoevskij per motivi di non opportunità, insiste a più riprese sulla necessità di separare le sfere della politica e della produzione artistica e sottolinea le analogie tra il clima di chiusura attuale e quello del tempo di Achmatova. Nata a Odessa ma vissuta quasi sempre a San Pietroburgo/Leningrado, Anna pensava, parlava, scriveva in russo e non può essere considerata né russa né ucraina, poiché la sua patria è stata la lingua russa e lei è stata semplicemente un poeta russo, come voleva essere chiamata.
Il libro ripercorre l’intera vita di Anna Achmatova, contestualizzandola: la giovinezza, i tre matrimoni infelici e il rapporto distante con il suo unico figlio, le due guerre e la Rivoluzione bolscevica, la fucilazione del primo marito, i ripetuti arresti del terzo marito e del figlio, la condanna pubblica della sua poesia, definita morbosa e non in linea con il realismo socialista, il divieto di pubblicazione e la circolazione clandestina della sua opera, la paura, ma anche la gloria e l’enorme notorietà. La sua poetica è raffinata e originale, così diversa da quello in voga nella sua epoca. Sia quando si concentrano sulla dimensione più intima che quando si aprono alla visione di un dramma collettivo, i suoi versi restano sempre aderenti all’esperienza comune, illuminandola però di una luce che la rende “più vera, più potente, più reale”. Con un linguaggio sobrio e accurato, la sua poesia esprime sentimenti e relazioni, processi psicologici ed eventi dell’anima, in tutta la loro complessità e pienezza di sfumature. “Le poesie dell’Achmatova sono un raggio di sole che penetra in una stanza buia, la stanza nella quale ci troviamo un po’ tutti, con il nostro sguardo distratto, di persone convinte di conoscerle, le proprie stanze, le proprie cucine, le strade che percorrono per andare a lavorare, convinte di non avere niente da imparare, nella propria casa, nella propria città, nel proprio mondo”.